MEMORIE DI UN DISCEPOLO
- Details
- Category: Letteratura
- Published on Wednesday, 21 March 2018 03:35
- Written by Francesco Frigione
- Hits: 5918
MEMORIE DI UN DISCEPOLO

racconto di Francesco Frigione
«Nell’Anno del Signore 398, ricevetti una grazia.»
Palladio fece cenno al giovane di accostarsi: parlare gli costava fatica. Nella nuda stanza della Galazia, dove il vescovo dettava quel seguito alla Historia Lausiaca che mai avrebbe concluso, il vento insinuava spifferi simili a un presagio di morte.

Il giovane scrivano avvicinò ancor di più lo sgabello allo scranno di Palladio.
«La Cellia, il deserto egizio che avevo scelto per inchinarmi alla gloria dell'Onnipotente, era una terra inospitale per il corpo e aspra per lo spirito.»
Il novizio fece un cenno col capo, per suggerire che seguiva.
Palladio continuò:
«Avevo già trascorso alcuni anni sotto l’augusta guida di Macario, in quei pietrosi anfratti in cui si pregava e ci si fustigava dall’alba al tramonto, e per questo mi reputavo forte nel fisico e forgiato alla rinuncia dei beni terreni. Una tale convinzione era già segno di una smisurata vanagloria!», soggiunse severo, come a commentare un’obiezione del discepolo.

«Avevo quindi raggiunto la comunità di Evagrio Pontico, colui che ha descritto nell’Antirrhetikos gli spiriti malvagi che affliggono l’asceta votato alla pace interiore.
Parlare di comunità è in parte fuorviante, dato che ognuno di noi viveva in solitudine nel suo antro o in piccole celle di mattoni. Bevevamo e mangiavamo con parsimonia e dormivamo sulla nuda terra. Inginocchiati, tessevamo le nostre orazioni, un filo tenace e invisibile che dalla misera condizione di peccatori s’innalzava al Cielo. Spesso perdevamo la cognizione del tempo e dello spazio. I dardi dell’astro divino c’infocavano la pelle di giorno e il ghiaccio acuminato delle stelle ci penetrava nelle ossa di notte.»

Il giovane sollevò gli occhi sul vecchio con un misto di angoscia e pietà.
«Quando oramai m’illudevo di essere invulnerabile alle privazioni, mi prese una irrequietezza, per cui mi distraevo dalla preghiera, come in attesa che qualcuno si presentasse sull’uscio della mia cella. Sulle prime non diedi importanza alla cosa. Poi, però, la mia afflizione aumentò. Iniziai a provare difficoltà nel concentrarmi sulle Scritture: dovevo più volte riprenderle e da ogni lettura ricavavo la sensazione di intenderne meno.
Ben presto crebbe in me l’esasperazione. Me ne andai, dunque, in cerca dei compagni più vicini per attaccar briga con loro. E ripetei queste peregrinazioni più volte, sempre più avvelenato dall’ira e dalla bile nera.
Quando infine rientravo nella mia casupola, avvertivo un senso di disfatta e di vergogna. Persi la voglia di svegliarmi al mattino e, catturato da un tristo torpore, giacqui spossato non desiderando più rivedere il giorno.»

Palladio posò lo sguardo sullo scrivano per valutare l’effetto delle sue parole. Il ragazzo sembrava smarrito e il vegliardo assentì gravemente.
«Quando l’opera del Maligno pareva essersi compiuta ed egli già artigliava la mia anima inerme, la tenda del cenobio si sollevò. Aprii gli occhi terrorizzato. Scorsi una malferma figura che incedeva verso il mio giaciglio: era Evagrio.
Non mi dette tempo di reagire: m’impose la mano sulla testa e tracciò il segno della croce. Quindi disse: “Palladio, esci da quest’abisso di acedia e tristezza! Un angelo mi ha visitato in sogno, additandomi una fonte di acqua vergine e un assetato allo stremo che le volgeva le spalle. Accorso per aiutarlo, ho scorto il tuo corpo smagrito e lo stesso viso spento che adesso mi mostri”.

“Cosa devo fare, padre santo?”, gli chiesi confuso.
Alzati, lavati e riprendi i tuoi abiti mondani. Recati ad Alessandria e trovati una donna, la più bella e sensuale che colà pratica l’arte del meretricio. Resta con lei fintanto che non sazierai ogni desiderio della carne. Poi decidi se la vita dell’uomo di Dio è quella che aneli o se il tuo cammino sia un altro.

Adesso preparati a partire”.
Lasciò cadere dalla bisaccia un sacchetto di monete d’oro, una tunica, un mantello e dei sandali di cuoio. E si allontanò.»
Il giovane scrivano teneva adesso gli occhi sbarrati su Palladio. Inghiottì della saliva prima di domandare: «E voi, padre, che faceste?»

«Obbedii, naturalmente. E subito scoprii che desideravo ancora il mondo. Trascorsi più di sei mesi tra terme, taverne e lupanari, godendo di ogni piacere. Quando il denaro si esaurì, trovai da lavorare come precettore presso una facoltosa famiglia patrizia, un’occupazione che mi consentiva una esistenza agiata, in cui sarei stato libero e di soddisfare le bramosie della carne e di coltivare gli studi»
Il ragazzo attendeva ammutolito la continuazione del racconto.
«Ma dopo nemmeno un anno, un turbamento mi sconvolse l’animo fino a farmi ammalare. Caddi preda di una febbre stremante. Poi, in una mattina, che temevo di non superare, ebbi una visione chiarissima e potente: Evagrio stava in piedi accanto al mio letto, avvolto da una veste splendida. Gli chiesi come mai mi avesse raggiunto da tanto lontano ed egli, con gioia, mi rivelò: “Vado finalmente nella casa del Signore, dove anche tu mi raggiungerai quando sarà il momento. Ma adesso è per te tempo di nascere alla vera vita …”.

Poche ore dopo ero completamente sfebbrato.
Trascorsi tre giorni, lasciai Alessandria e tornai nel deserto. Mi presentai al cospetto di Evagrio, ma puntualmente ne trovai le spoglie in putrefazione, vegliate dai confratelli: seppi che aveva abbandonato questa valle di lacrime nell'istante esatto in cui mi era apparso. Mi prosternai ai piedi della salma circondata dalle mosche e, piangendo, le resi grazie con tutto il mio cuore.

Da allora non smisi più la vita monastica, finché, come sai, le responsabilità della Chiesa non mi condussero a Elenopoli prima e a Roma poi, per perorare la causa del mio maestro Giovanni Crisostomo; quindi, a sopportare l’esilio a Siene; a pregare tra i monaci del Monte degli Ulivi e, infine, ad occuparmi indegnamente di questa diocesi di Aspona, che di certo sarà il mio ultimo compito terreno.»

Sopravvenne il silenzio.
«Perché, padre, avete voluto mettermi a parte dei vostri trascorsi?», chiese il giovane, timidamente.
«Perché la via per la salvezza è lunga e solitaria, mio caro amico, e se tu vorrai seguirla dovrai sempre confrontarti con le occulte insidie del Demonio.»
Il ragazzo arrossì.
Volgendosi in direzione della finestra, Palladio seguitò a parlare con tono pacato.
«Mi è stato riferito che l’avvenenza di una fanciulla ha eccitato la tua immaginazione: è vero questo?»
Lo scrivano non confermò né confutò l’affermazione, ma impallidì.
«È vero ... » asserì Palladio.

«Bene, sappi che non ti condanno. Non sta a me giudicare, ma a te solo. O meglio: è la voce del Salvatore che alberga nel tuo petto l’unica a poter rischiarare l’oscurità in cui brancoli. A te tocca riconoscerla, questa voce, e assecondarla. Poiché potresti cedere alla tentazione della lussuria e smarrirti nel peccato, oppure tradire te stesso per vanità, un altro tranello di Satana. Le rinunce della vita religiosa diverrebbero allora il tuo vanto. Non serviresti la virtù, dunque, bensì la superbia, un vizio capitale.

È difficile capire cosa è giusto fare in queste circostanze. Perciò, prega e purifica il tuo cuore. Cerca d’intendere quali tesori custodisca. E qualunque verità emerga non temerla: l’Eccelso ti manderà un angelo in soccorso.
Adesso va, ragazzo, e lasciami solo!»
Lo scrivano si genuflesse, baciò l’anello del vescovo e quasi scappò dalla stanza.

Il vecchio si pose a osservare, attraverso i vetri, la luce che declinava sui tetti e sulla campagna circostanti. Rapito dal tramonto, Palladio componeva ritmicamente sulle labbra il nome di nostro Signore Gesù.»
Appena il novizio ebbe superato la soglia, lo richiamò indietro:
«Mi raccomando: di quanto ti ho narrato, non far cenno a nessuno …».
***

Quel giovane ero io, Filomeno di Bitinia, figlio di Porfirio, mercante di stoffe.
Dopo penose esitazioni, decisi di lasciare il convento. Rimasi però un buon cristiano.
Divenni medico e naturalista ed esercitai a Costantinopoli. Sposai una dolce e devota fanciulla che mi diede molti figli. Ma, con mio enorme dolore, ella morì ancora in verde età.
Dopo un paio di anni, mi risposai ed ebbi altri figli.
Conquistai una posizione agiata e partecipai alla vita politica e sociale. Scrissi dei trattati di filosofia naturale non disdegnabili, sebbene, temo, destinati all’oblio.

Anche se, lo ammetto, ci sono momenti in cui rimpiango di non aver indossato il saio, queste malinconie presto mi abbandonano. Credo, infatti, che il Soffio divino pervada in vari gradi l’intero creato: in un fiore e in un passero, nella carezza di una donna e nel suo rimprovero muto, nell’impulso a procreare e nello sguardo di un figlio, nella cura del prossimo e in una guarigione; a volte persino nelle piaghe di un ammalato e nei gesti di un folle.
Altrettanto è diffuso il Male. Attimo dopo attimo assume forme diverse e tenta nuovi assalti. Conquista trofei, distrugge lande, disperde popoli, annienta cuori.
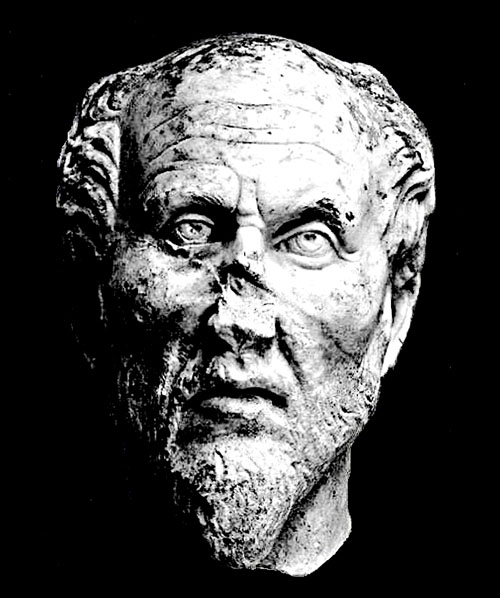
Il mondo è Paradiso e inferno, specchio e prodotto dell’infinita contesa tra Celeste e diabolico. E a noi tocca discernere: avvicinarci o fuggire, accogliere o respingere, abbracciare o combattere.
***
Oggi, ormai vecchio e ispirato da un vivido sogno, sciolgo il voto di segretezza e trascrivo l’insegnamento elargito da Evagrio a Palladio, e che questi trasmise a me.
E così come esso ha rischiarato il mio cammino nel mondo, così prego Iddio possa illuminare il lettore delle mie umili memorie.









